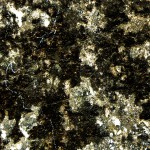(La lettura di questo aiuta a comprendere il mio punto di vista e l’articolo che segue)
Veramente difficile dire qualcosa di sensato e lucido riguardo l’intera faccenda, prima degli stacchi di pezzi di street-art dai muri di Bologna, poi della cancellazione, con una passata di grigio, da parte dello stesso Blu, delle proprie opere.
Forse la cosa più sensata sarebbe partire da quando sono arrivato a Bologna, anni fa, e per la prima volta ho visto un pezzo di Blu. Era il secondo giorno che stavo in città e sono stato invitato da alcuni amici a raggiungerli in un centro sociale, XM24, in cui non ero mai stato. Quando stavo per arrivare, da lontano, ho visto il muro di questo capannone ricoperto di murales diversi da tutti quelli che avevo visto fino ad allora. La schematizzazione dell’evoluzione umana, della scimmia che diventa uomo per poi regredire davanti la TV, non la scorderò mai. Mi ha accompagnato da allora. Così come gli umanoidi, mezzi uomo mezzi ibridi tecnologici (che però dalla tecnologia sembravano più soggiagati che amplificati) che vedevo davanti al supermercato in cui facevo la spesa, o vicino la sede della mia facoltà. I primissimi pezzi, quelli, rarissimi, in cui, prima di passare alla pittura Blu usava ancora gli spray, vicino la rotonda di San Donato o in una serranda di via Del Borgo. Man mano ho cominciato a far caso alle opere di questo artista così insolito che oltre a creare cose belle da vedere aveva sempre qualcosa di profondo da dire.
E’ stato bello e importante vederlo crescere e sentirlo vicino, prendere parte alle cose cui partecipavo. Dipingere le facciate dei nuovi spazi liberati a Bologna, dipingere durante la street-rave-parade lungo via Stalingrado, dipingere le serrande di posti come la libreria Modo Infoshop. E’ stato doloroso vedere le suo opere cancellate, dopo lo sgombero di posti come il Livello57, a causa di un amministrazione comunale che ha messo molto più tempo di tanti cittadini a capire cosa stava succedendo sui suoi muri. E’ stato bello ritrovarlo in viaggio, a Berlino, non solo nei tre grandi murales di Kreuzberg (due dei quali hanno subito la stessa fine dei suoi lavori bolognesi), ma anche proiettato fuori dai muri del Tacheles. Si è rapportato a tutti i livelli con il mondo dell’arte ufficiale (dalla biennale del muro dipinto di Dozza, fino alla Tate Modern di Londra, ma non ha mai perso di vista le motivazioni alla base del suo lavoro. E anni dopo queste esperienze me lo sono ritrovato accanto, durante un corteo No-Muos, a Niscemi, Sicilia. Dove ha dipinto dei murales anti-militaristi. Ha girato il mondo (si pensi alle sue opere in sud-america) ed ora è tornato a Bologna.
Questa lunga introduzione serve a far capire un punto importante della vicenda: Bologna senza le opere di Blu è una città ferita. La vicenda del murales Occupy Mordor, sui muri di XM24, lo testimonia. (Chi dice che ora che il murales non c’è più a rimetterci è XM24 che rischia di nuovo non ha ben capito come stanno le cose. La differenza non la fa un disegno sul muro, ma il gesto e l’impegno collettivo che portano alla sua realizzazione)
Ripartiamo dunque: qualche settimana fa leggo un’intervista ad un curatore che starebbe organizzando a Bologna una mostra dedicata alla street-art, staccando le opere dai muri per metterle dentro un museo. Nell’articolo in questione la tesi del curatore è più o meno questa: da sempre ci si impossessa di oepre d’arte e le si pone in mostra, anzi così facendo le si conserva, anzi io sono yeah perchè ho preso anche quelle illegali, se avessi optato per un’intervento di restauro in loco (che nessuno ha chiesto…) avrei potuto operare solo su quelle realizzate legalmente, a me quello che importa è creare una discussione (che anche questa nessuno ha chiesto e ad ogni modo gli stacchi delle opere erano cominciati già da tempo) e se qualcuno degli artisti farà appello al diritto d’autore vuol dire che usa gli obsoleti mezzi del capitale. Non perderò tempo su questa intervista.
Sarebbe invece il caso di perdere un minuto sul finanziatore (di fatto) della mostra, Fabio Roversi Monaco, il quale è a capo di Genus Bononiae, polo museale cittadino, finanziato dalla Cassa di Risparmio di Bologna. Con l’aiuto di una serie di imprenditori, tutti fulminati dalla streetart sulla via di Damasco e tutti, guarda caso proprio ora, preoccupatissimi di salvare le opere dal deterioramento e dalla distruzione, Roversi Monaco dice di essere andato, in pellegrinaggio evidemente, in giro per fabbriche e capannoni abbandonati a vedere coi propri occhi opere destinate all’oblio e di aver deciso di salvarle. Consigliato, si intende, dai curatori di cui sopra. Fa sorridere che un massone, accentratore di cariche, amico dei palazzinari, presidente di Banche e fondazioni, che mi immagino gettare odio quando un’opera d’arte salva dalla speculazione un centro sociale (come ha già fatto Blu) all’improvviso si interessi alla streetart, proprio quando questa sia all’apice dell’appeal consumistico, della patinatura capitalistica, slegata, nella gran parte dei casi, da qualsiasi contesto urbano e muova molti soldini.
Fatto sta che sulla porcata di Bologna, al di là delle polemiche di infimo grado che hanno trovato posto sui giornali, molti degli artisti coinvolti hanno preso posizione per tempo.
Ericailcane, ad esempio lo ha fatto così.
Nemo’s, invece, così, criticando in certo senso il concetto stesso di street art, per come viene genericamente indicata, come un qualcosa simile ad uno dei bisogni che il capitale crea negli individui perchè possa lucrare sulla sua soddisfazione.
Soviet e Never2501 così, parlando di un processo di sottrazione e saccheggio.
Mentre Dem ha cancellato alcune delle proprie opere, assieme a Blu, come ad esempio quelle sulla facciata della prima occupazione di Bartleby.
Pochi giorni fa inoltre, è utili ricordare ai fini della contestualizzazione, l’Artista AliCè è stata condannata al pagamento di una penale, a causa di uno dei suoi murales in città.
Insomma per venire ai fatti tra stanotte e la giornata di oggi Blu ha cancellato tutte – o quasi- le sue opere presenti in città. E qui va sottolineato il secondo punto importante: una scelta così, da parte di Blu, non può che essere una scelta tremendamente dolorosa.
Il comunicato ufficiale è stato affidato al blog di Wu Ming ed è, a mio avviso, l’unico documento che abbia senso leggere al momento. Quindi, per continuare la lettura di questo articolo, è necessario che lo leggiate, ora.
Il gesto di Blu ha scatenato isterismi e sproloqui sia in rete che in città ma ha fatto anche venire a galla contraddizioni interessanti all’interno degli stessi ammiratori dell’artista e dato una nuova prospettiva al fenomeno street art.
Alcune considerazioni riguardo i detrattori di Blu:
-Non tutti sono daccordo con quanto fatto da Blu. Lo accusano ad esempio di aver agito egoisticamente. Eppure è evidente che intrinsecamente le opere di Blu siano di e per tutti, e che qualcuno voglia in qualche modo privatizzare quelle esperienze, la cosa più naturale è che esse spariscano. Se si ama Blu, non si può non capire questa dolorosa scelta. La sua arte è un’arte collettiva, non può esistere senza un contesto e una comunità che la significhi. Inoltre Blu non ha agito da solo: gli abitanti del quartiere, i ragazzi XM24 e Crash, la banda Roncati, lo hanno aiutato. La “sua” comunità lo ha appoggiato, perchè ha capito che stava facendo qualcosa “per” e “con” Bologna e non “contro” Bologna. Ovvero stava mostrando a tutti cosa diventerà Bologna se si avvallerà la visione “privatistica” di chi ha organizzato tale mostra: una città grigia.
-Alcuni dicono <<Ora che ha cancellato le sue opere su quei muri appariranno orribili tag>>. Eppure questo (come messo in evidenza ad esempio da @zeropregi) è un altro dei nodi del discorso. Fino a quando allargheremo le fila dei consumatori di street art patinata, disposti a spendere per comprarla, ignoranti al punto giusto delle origini del writing, sarà tanto più leggittimato chi vorrà relegare l’arte di strada in un museo, facendo distinguo insensati. A questo punto deve essere chiaro che non si può stare con Blu ed essere contro l’arte di strada, tutta. (E comunque sì: le cose sono legate! Streetart – writing – muralismo e arte urbana hanno radici culturalmente diverse ma fare distinguo di valore in base ai quali assegnare o meno una presunta leggittimità ad esistere è una roba da imbecilli).
-Ancora su questo discorso: Cosa è degrado? i writer che fanno scritte e scarabocchi sui muri? Ma anche Blu, prima di diventare uno dei 10 streetartist più quotati del mondo (secondo il Guardian) ha cominciato facendo scarabocchi sui muri. Dunque la questione è controversa… La parete grigia, se vuoi, è una pagina bianca da cui ricominciare. Gli scarabocchi, se vuoi sono prove di giovani artisti. Il potere vede il “degrado” dove ha interesse ad arrivare con la speculazione e vede “arte” dove le opere sul muro hanno valore sul mercato!
-E ancora: come interpretare dunque, da parte del potere cittadino, le numerose iniziative antidegrado volte a ripulire le città da forme stilistiche verso cui non si dimostra neanche l’intenzione di un approfondimento; e volte alla criminalizzazione di giovani writer? E che dire dei militanti di Crash, denunciati perchè sorpresi a cancellare i murales di Blu?
-Alcuni temono che la cancellazione delle opere rappresenti una resa davanti all’avanzata di un altro degrado, questo si spaventoso e reale: quello della speculazione edilizia. Ma questa visione equivarrebbe alla feticizzazione delle opere di Blu, che sono, è vero, un simbolo di lotta alla gentrificazione, ma che non possono nè devono però sostituire l’unico antidoto all’avanzata del cemento: una comunità cosciente in lotta!
-Alcuni vedono nelle opere scomparse il pericolo di un processo di “degradazione” del territorio. Le opere lo abbellivano. E ora?… Ma anche qui sarebbe il caso di ricordare che le opere di Blu non servono ad abbellire un paesaggio, ma a testimoniare processi in atto e comunità che abitano dei luoghi. Il degrado, non solo a Bologna, è una delle scuse preferite dallo stato e dagli sciacalli amici di Roversi Monaco per reprimere i movimenti e privatizzare. Blu non può essere portato ad esempio di “lotta al degrado” in quanto nella maggior parte dei casi quello che le autorità chiamano degrado è creatività e aggregazione gratuita.
-Ad alcuni semplicemente dispiace per le opere. Si, Anche a me. Mi sento come se un lungo pezzo della mia vita, un terzo della mia vita, fosse stato cancellato. Mi sento ferito. Ma come dicevo sopra le opere in questione sono l’esito di un impegno collettivo. Sebbene le realizzi Blu, esse appartengono sempre ad una comunità (vedi i suoi lavori in Val di Susa). Se oggi Bologna è questo, tanto vale prenderne atto e ricominciare, da un muro grigio.
-Ad alcuni sembra che Blu abbia fatto qualcosa contro di loro e contro la loro città. E questa è l’accusa più incredibile, quella che fa apparire le contraddizioni maggiori. Basta pensare al caso di Berlino. Lì è stato chiaro a tutti che Blu ha cancellato i suoi murales, in accordo con la comunità punk che viveva nella zona, per loro, per appoggiare la loro battaglia contro la gentrificazione. Qui deve essere altrettanto chiaro che Blu si sta schierando dalla nostra parte: dalla parte di quelli che vogliono l’arte libera, gli spazi pubblici, le esperienze collettive. Sta facendo una cosa per noi e con noi. Se a qualcuno questo non torna, quel qualcuno non sta dalla stessa parte dell’artista, evidentemente.
-Riguardo questo fatto mi preme dire che trovo inaccettabile l’idea che i lavori di Blu possano avere una mera funzione consolatoria. Si, le cose vanno male, il capitalismo avanza, ma almeno quando vado a XM24 mi guardo Blu, che fico. Non capire il dolore e la ragione che sta nell’essere orgogliosi del proprio muro grigio è assai singolare per chiunque appoggi le idee e le pratiche messe in campo in spazi sociali come, appunto, XM24. Le opere di Blu sono mezzi e azioni che fanno parte di un discorso/azione anticapitalista in atto. Quando si dice di ammirare le sue opere bisogna prenderne atto.
-Per alcuni Blu, avendo in passato esposto in gallerie d’arte, non avrebbe il diritto di opporvisi, ora. Come se la sua fosse una protesta guidata da narcisismo o da motivi privati. Come se di mestiere non facesse, comunque l’artista. A tal proposito vale anche la pena ricordare gli episodi di censura alle sue opere. A Roma (nell’ambito del SanBa) e a Los Angeles (sulle pareti del MOCA).
E ancora:
-C’è chi dice (i curatori, soprattutto) che la mostra in questione offre la possibilità di un restauro e una conservazione delle opere quando, a mio avviso, parlare di “conservazione” e “restauro” riguardo l’arte di strada dovrebbe di per sè squalificare una persona dal ruolo di curatore artistico… (L’arte di strada non ha senso fuori contesto ed è effimera. Blu lo ha specificato per bene, col suo gesto)
-C’è chi dice che ha solo accresciuto l’interesse e l’attenzione nei confronti della mostra in questiona. Bene. Cerchiamo di usare l’attenzione e l’interesse in questione per dire una cosa semplice: La responsabilità di quanto accaduto è di Genus Bononiae, nella persona di Roversi Monaco e degli accondiscendenti curatori, e dei loro amici finanziatori! Quello che Blu ci sta mostrando è esattamente la città che traspare dalla loro visione privatistica dell’arte (e in genere).
-Inoltre, cosa avrebbe dovuto fare? Creare un’opera di denuncia, col rischia che venisse fagocitata dallo stesso sistema che voleva criticare? Il suo gesto, in un certo senso, è proprio esso stesso una performance artistica “per sottrazione”: ha cambiato il volto alla città e ha emozionato e fatto piangere molte persone!
Tanti altri sono i temi toccati dagli avvenimenti bolognesi:
– Cosa è veramente la streetart? Esiste in quanto tale, si riferisce ad uno stile, o è piuttosto una categoria fluida usata per mercificare e lucrare?
– Come affrontare in definitiva il problema della mercificazione delle controculture che, dal punk in giù, sono sempre state messe a profitto del capitale?
– Come affrontare la questione riguardante i Centri sociali e in generale gli spazi di socialità, sempre più a rischio e ridotti all’osso non solo a Bologna ma vere fucine delle novità espressive che nascono sul territorio.
In che ottica è giusto guardare le polarità pubblico/privato e personale/collettivo in una questione del genere? Le opere possono essere privatizzate in nome di un bene superiore, ma se l’autore le cancella si dice che sta agendo come se fossero sue, private. Le opere si vorrebbero pubbliche, di tutti, se l’autore le cancella, per mettere a fuoco il pericolo di una privatizzzione ci si dispera perchè sono opere pubbliche. Starebbe quindi lui sottraendo opere pubbliche a tutti? Se non lo facesse ne avvallerebbe però la privatizzazione. L’autore ha agito non da solo, ma con una comunità: dunque ha agito “con” e “per” la città. Pur sottrendogli delle opere. Mentre gli organizzatori, pur avendo agito in team, hanno deciso tutto da soli forti del potere datogli dalle possibilità economiche: loro si hanno agito personalmente, deliberatamente in maniera individuale sulla base di una autoassegnazione di competenza, sottraendo delle opere dal loro contesto.
Mi pare che Blu abbia fatto un bel po’ di cose belle con questo suo gesto:
-Intanto ha fatto rimanere di merda Fabio Roversi Monaco e i suoi amici curatori, che fino a ieri si crogiolavano nelle interviste parlando di Blu e dicendo che non aveva espresso alcun parere sulla mostra. Beh, diciamo che ora qualcosa ha detto…
-Ha realizzato, nel bene o nel male, una straordinaria performance artistica. Perchè arte non può essere solo qualcosa di materiale o estetico. Con questo gesto Blu ha cambiato il paesaggio urbano, ci ha emozionato (tristezza e gioia allo stesso tempo), ci ha fatto sperare e disperare, ha mandato un messaggio chiaro e ci ha dolorosamente messo nella condizione di rinunciare a qualcosa di bello, che forse davamo per scontato. “Se non è arte questa” (cit.).
-Ha messo in chiaro che i suoi sono “atti di cittadinanza” contro la gentrificazione, prima che opere d’arte. Ed ha in qualche modo rilanciato la domanda «Chi comanda in città? Chi decide?» centrale in numerose campagne politiche “dal basso” cittadine. Non solo: le sue opere non sono solo opere, ma agiscono e trasformano il territorio che le ospita e ispira. Accettare una loro decontestualizzazione equivarrebbe tout-court ad accettare una loro negazione. Mentre tenere in vita quelle opere è possibile, qualche modo, solo non rinunciando al proprio “diritto alla città”.
-Ha in qualche modo sottolineato l’importanza delle sue opere per la città. (ahinoi…)
-Ci ha scomodato. Ed a volte è necessario che sia così. Dalla confortante e quotidiana visione delle sue opere.
-Ha accettato di battersi rinunciando al diritto d’autore, il quale gli avrebbe consentito di evitare facilemente che le sue opere venissero esposte!!! Ma, per coerenza, criticando egli stesso il diritto d’autore in quanto mezzo che ostacola la libera circolazione del sapere, Blu non ha voluto appellarvisi. Questo anche la dice lunga sul personaggio…
-Ha inoltre messo l’accento sulle situazioni reali di fermento alla base di esperienze come la sua. La maggior parte dei suoi lavori si trovavano sui muri di spazi sociali autogestiti, gli stessi che questa città sta progressivamente eliminando, mentre si erge a salvatrice della street art. (Di Occupy Mordor è sopravvissuto solo un pezzettino di Atlantide).
Ma in definitiva ha soprattutto:
-Incollato gli organizzatori alle proprie responsabilità: volete una città in cui questo tipo di arte sia fruibile a pagamento? Bene, eccovi accontentati. Eccola. L’avete chiesta voi.
-Una volta per tutte ha detto: o sono per tutti o non sono per nessuno.
—
Altri dubbi, in attesa di una rielaborazione del testo:
– Quali sono i mezzi in possesso di uno street artis per far si che la sua arte non sia manipolata? (Esempio di Banksy). Ad esempio notare che un modo per essere liberi è fare (come mi ha detto si twitter @Arteria_antifa) “qualcosa che non è imposto” e, in definitiva, qualcosa di transitorio.
-Quali strategie possono mettere in campo gli streetartist per evitare che la loro opera favorisca i processi di gentrificazione? (Esempio di Spuistraat ad Amsterdam, dove l’intervento repressivo a posto fine ad una esperienza annuale di occupazioni salvando solo gli edifici resi “prestigiosi” da determinati interventi di street art. La qualcosa genera una frattura all’interno del movimento stesso, se ve n’è uno. E questa composizione – quella degli “streetartist” è proprio uno degli elementi di discussione).
-Quali strategie mettere in campo a Bologna? Dipingere tutto di grigio, proporre agli artisti di utilizzare solo muri pubblici, organizzare eventi di disegno pubblico collettivi o portare avanti altre forme di lotta? Si potrebbe provare a mettere il dito nella piaga dell’arte cosidetta “ufficiale” che, come fa notare qualcuno nei forum, attraversa momenti di empasse, anche a causa dei quali guarda al mondo streetart.
—-
Riflessione a parte:
Le opere di Blu prima che oggetti sono testimonianza di una comunità e opera di una collettività radicata su un territorio. Di conseguenza al cambiare di determinati fattori socio/territoriali esse mutano o scompaiono. Un pezzo di muro asportato dal suo territorio non può essere un’opera di Blu, checchè ne dica qualche prezzolato critico. Viceversa, la cancellazione collettiva delle sue opere – per mano della comunità stessa che quelle opere aveva visto nascere e sostenuto – è un’opera di Blu.